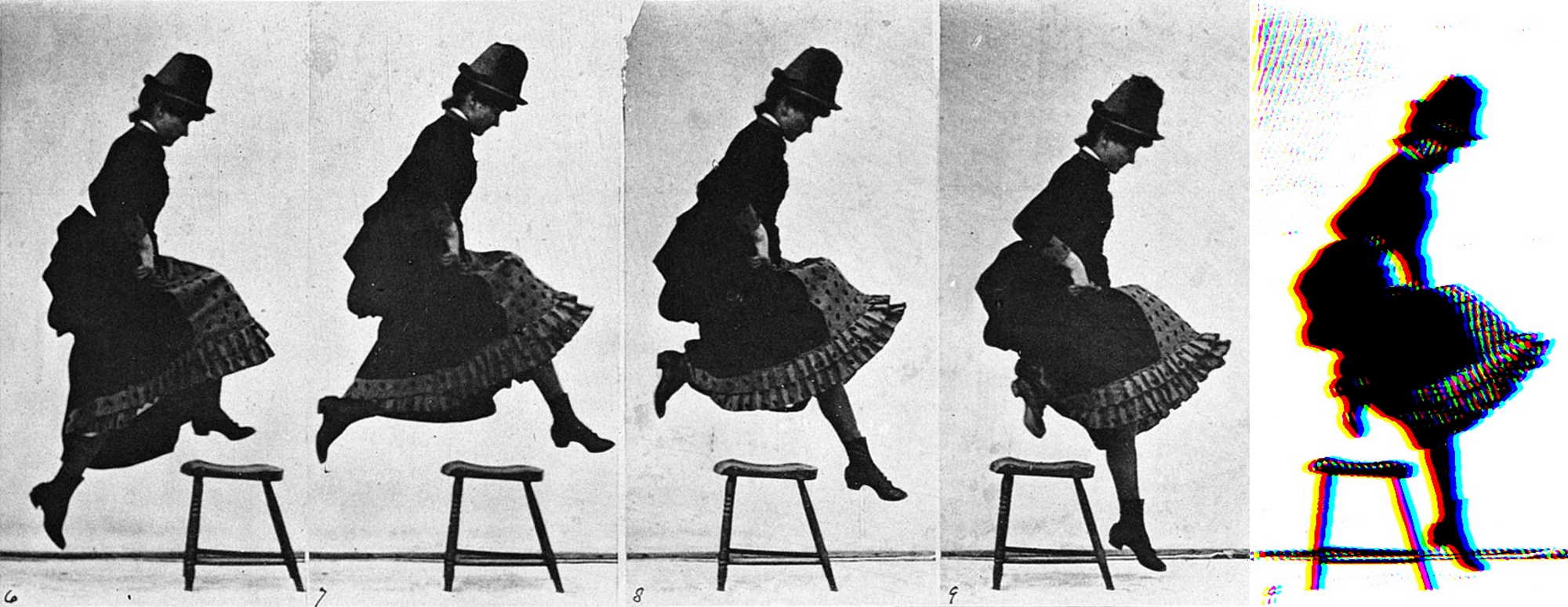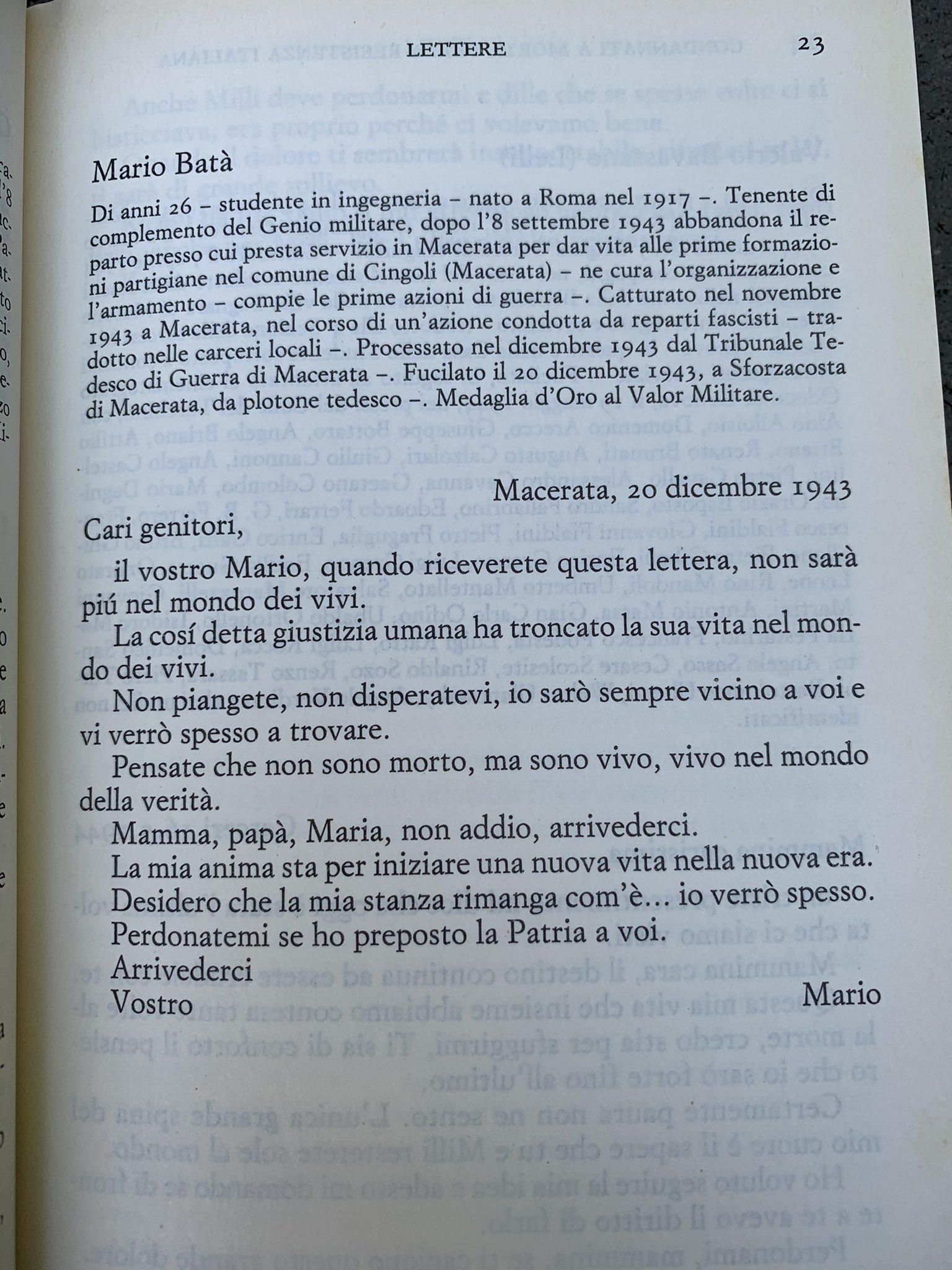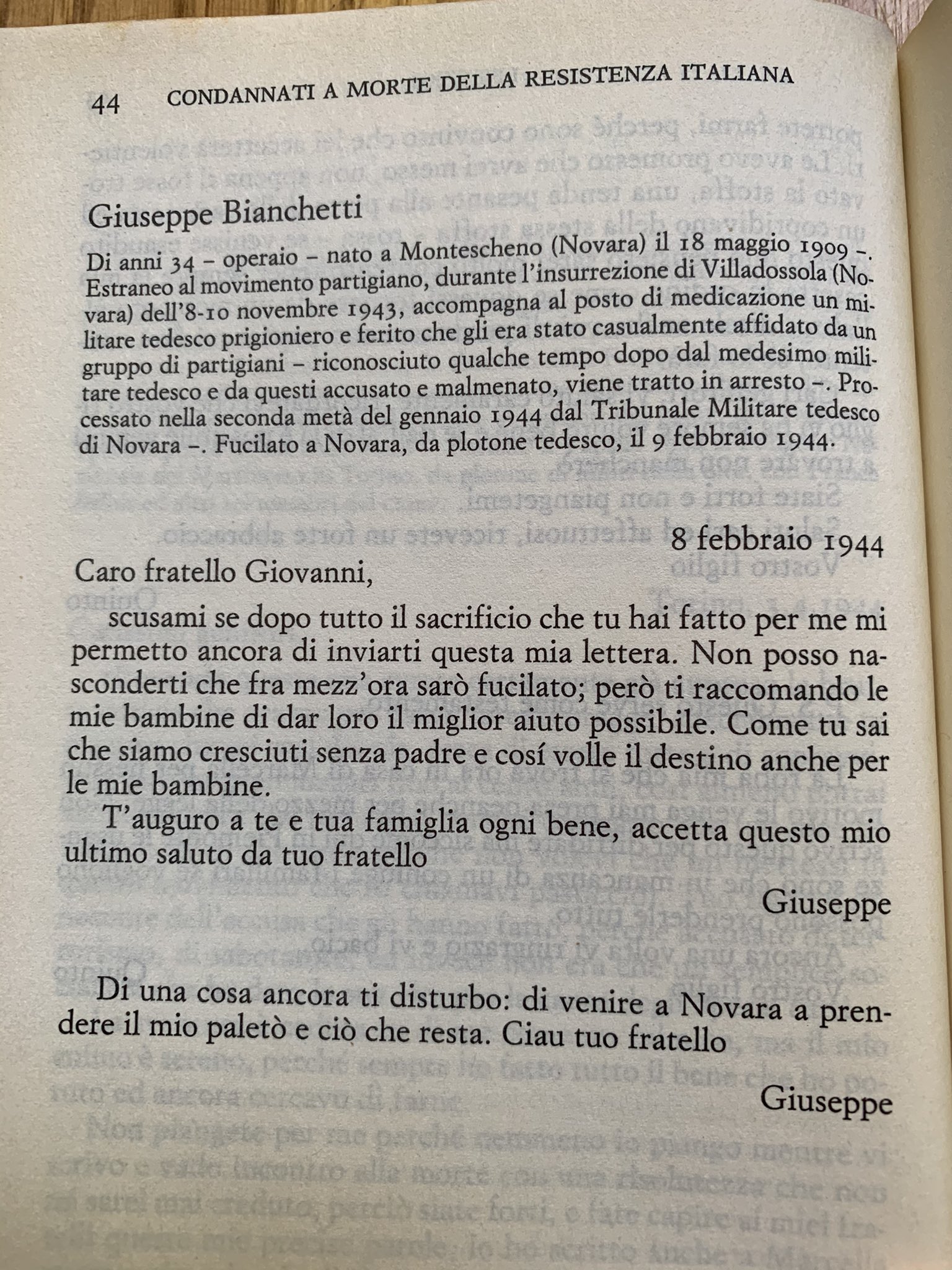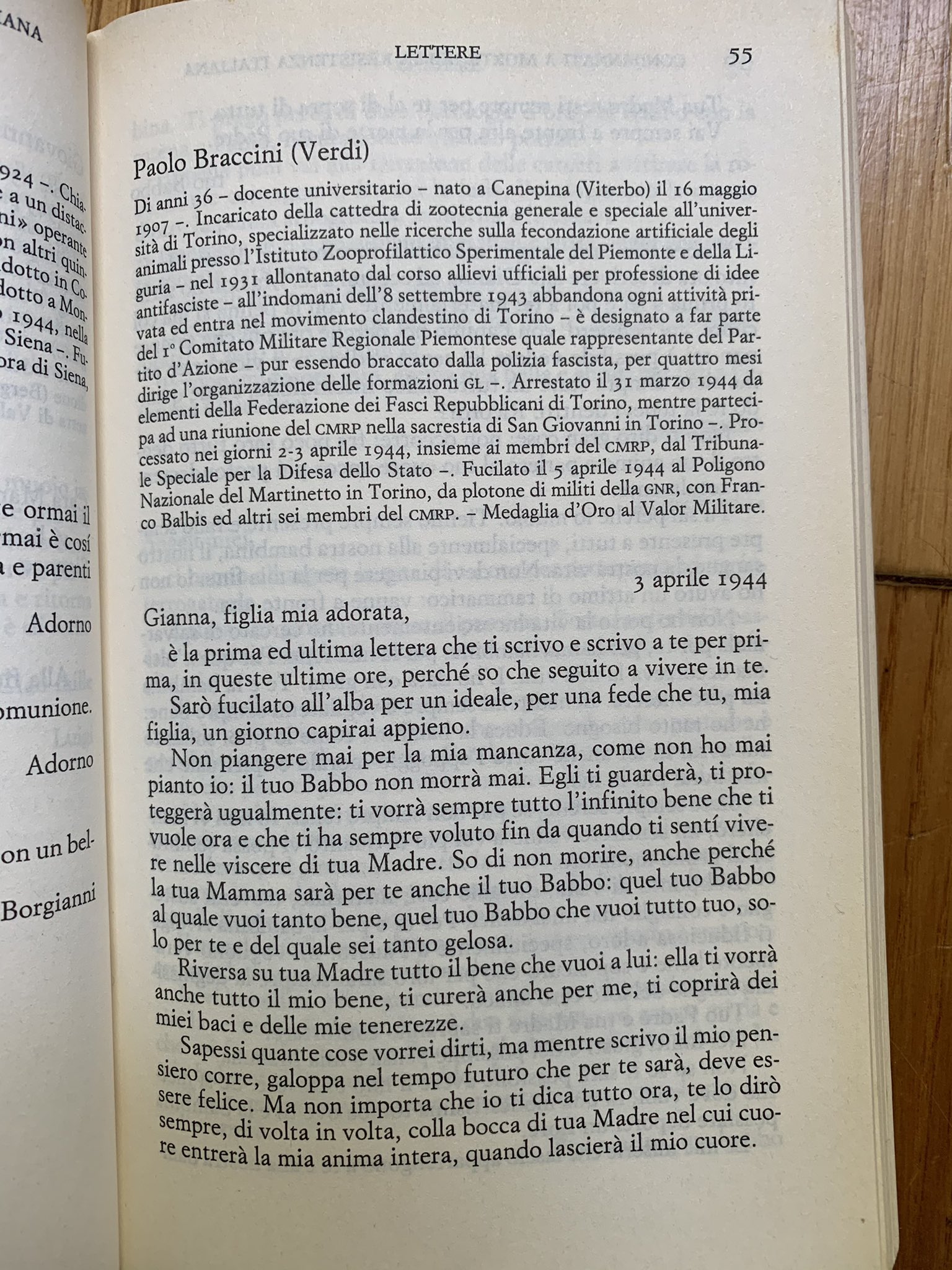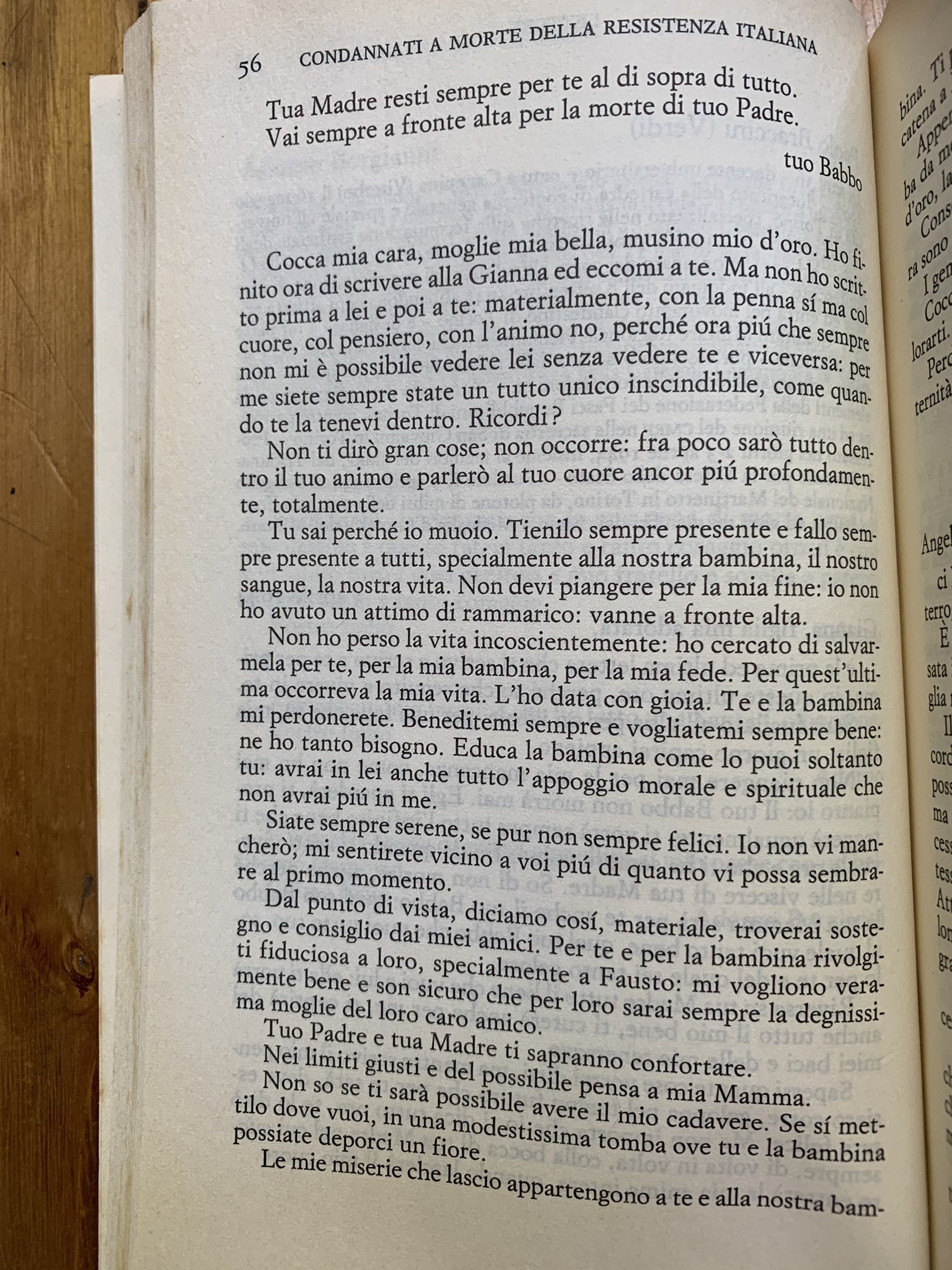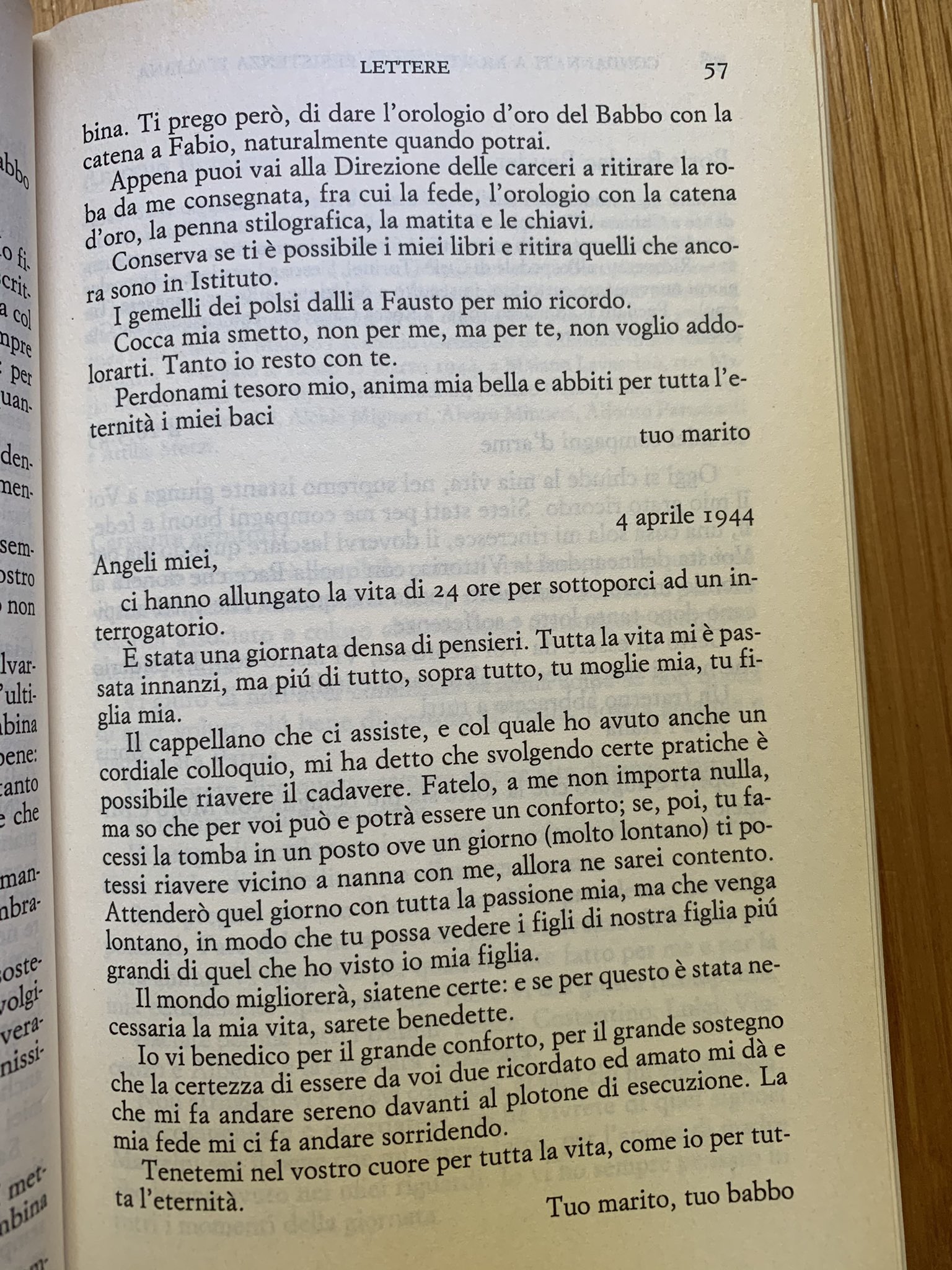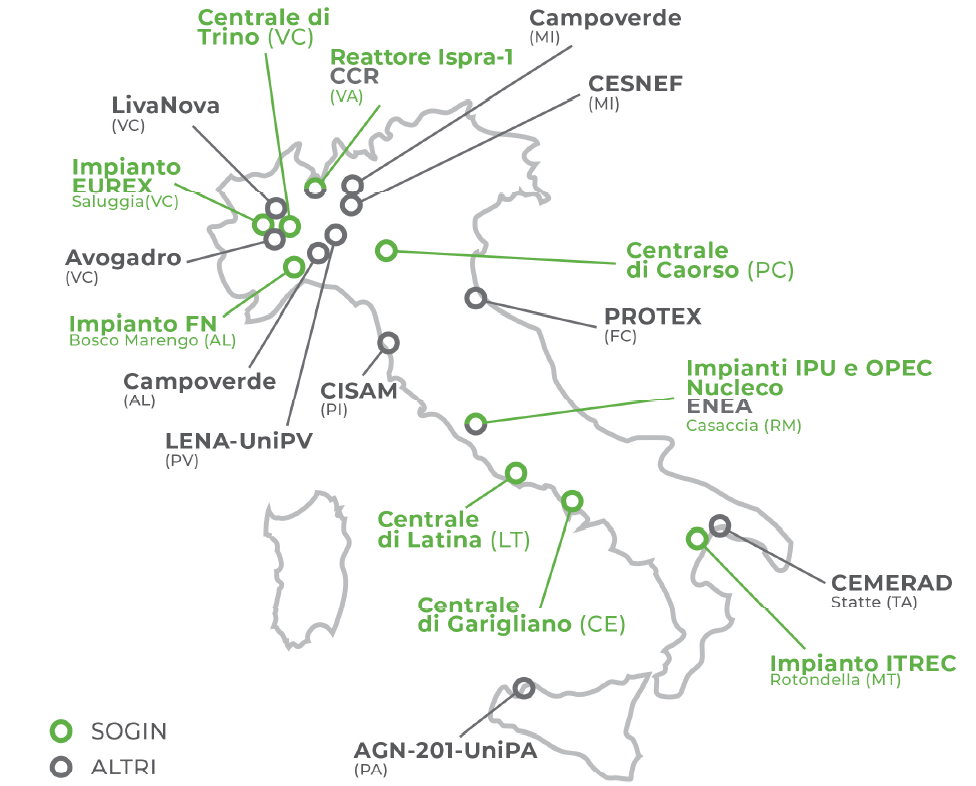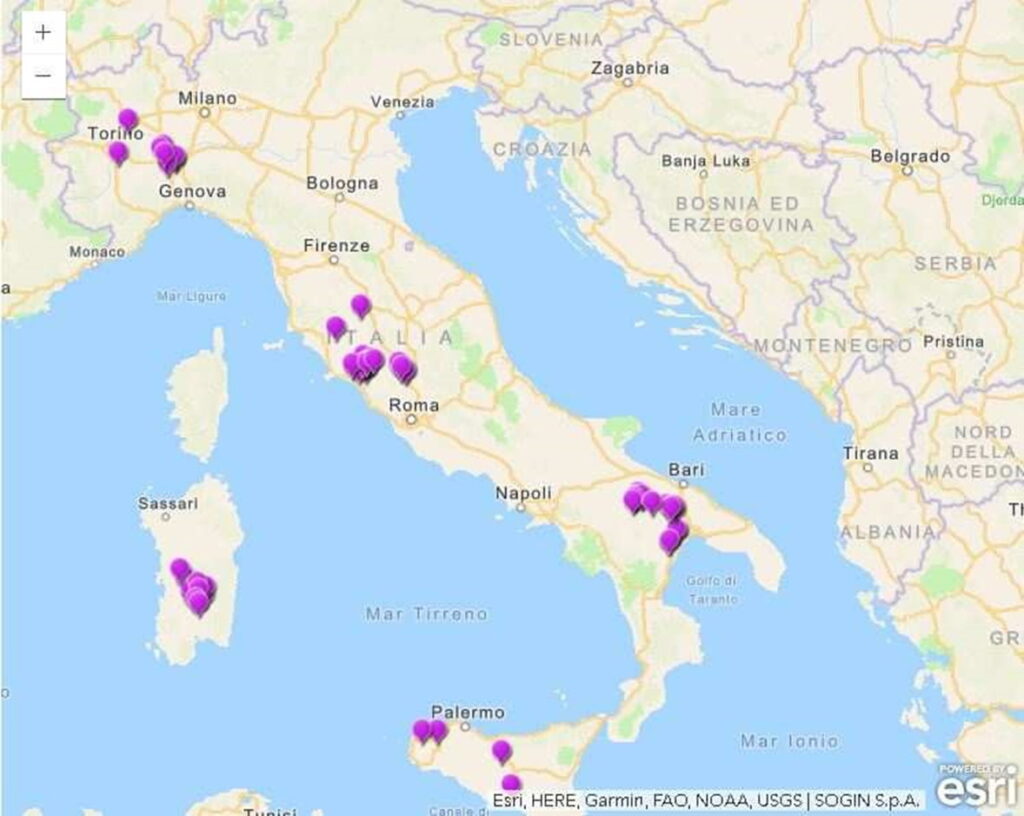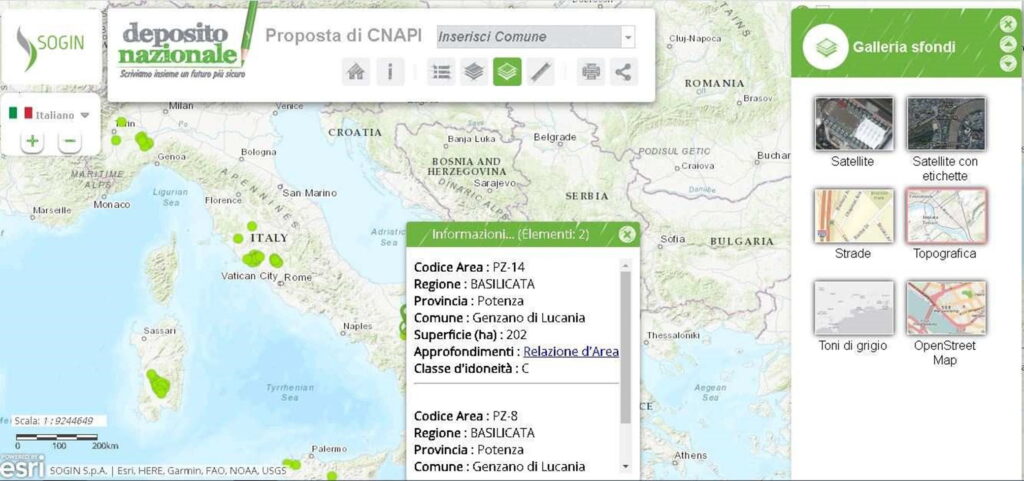Di libri, di creatività, di ambienti di comunicazione e del progetto RApP.
Premessa
Premessa? Nessuno ama le premesse. Se anche voi siete così pigri, cliccate qui e saltate al resoconto).
“Se gli dai diritto di parola, poi hai il dovere di ascoltarli”, lo diceva sempre il mio maestro di comunicazione. Lui si riferiva ai social media e lo diceva per criticare l’uso che se ne fa da parte dei grandi content creators. Quelli che raccolgono followers a K e a M (sì, insomma, a migliaia e migliaia e migliaia). Un vero e proprio broadcasting alla vecchia maniera, solo trasferito sulle piattaforme digitali di conversazione.
Già, la conversazione… La promessa di una big conversation che sul finire degli anni ’90 ha rivoluzionato il panorama mediale.
Nasceva la nuova generazione degli ambienti di comunicazione e un gruppo di tecnoentusiasti lanciava un messaggio alla gente della Terra (…People of Earth) per tracciarne l’anatomia e la fisiologia; la prima tesi era perentoria: “I mercati sono conversazioni” (Markets are conversations).
Era il Cluetrain Manifesto a cura di Rick Levine, Christopher Locke, Doc Searls, David Weinberger ed era l’epoca in cui le piattaforme di blogging avevano cominciavano a dare la parola a nuovi scrittori e, attraverso le aree commenti, anche ai nuovi lettori. Una conversazione appunto, attraverso una semplice textarea e il tasto invia.
Una stagione entusiasmante. Oggi però sta diventando una stagione all’inferno. Tra hate speech, fake news, cyber bullismo e complottismi tra i più fantasiosi.
I bambini, perché nessuno pensa ai bambini? [scil.]
Non so ai bambini (che forse ne sono ancora esclusi), ma agli adolescenti qualcuno sì, ci pensa. E quello che emerge è che per loro… è complicato. Ce lo dice danah boyd nel suo It’s complicated. La vita sociale degli adolescenti sul Web (se non lo avete ancora letto, cosa aspettate? Per di più se siete anglofoni potete scaricarlo gratuitamente dal sito dell’autrice).
Gli adolescenti sono alcuni dei soggetti più immersi nella big conversation entrata nella sua stagione infernale. Là negli ambienti digitali è complicato. Ci sono gli adescatori di minori, si diceva un tempo. Ed è vero (perché c’è di tutto in quegli ambienti, che sono un pezzo di mondo, il nostro mondo di oggi, con tutto quello che a mano a mano ci coltiviamo), ma a rendere complicata la situazione non sono solo gli orchi, perché ci sono anche tante altre bestie. Ad esempio la Bestia di Salvini, che si aggira a suo agio su Facebook e ha provato a marcare il territorio anche su TikTok.
E cos’è TikTok? TikTok – ma un ambiente vale l’altro – è il nuovo muretto dove gli adolescenti si ritrovano lontano dai like indiscreti degli adulti, delle mamme e delle zie imbarazzanti, dei papà e degli zii imbarazzati, degli insegnanti e delle insegnanti imbarazz… (con la emme o con la enne???).
Una volta se stavi su Myspace… no scusate, prendiamola meno alla lontana, altrimenti non mi farò mai capire. Una volta se stavi su Facebook avevi una certa età e incontravi i tuoi pari età. Poi è successo che la piattaforma ha raggiunto trionfalmente il miliardo di utenti e si è verificato quello che i sociologi chiamano collasso dei contesti: su Facebook – ma, ripeto, il discorso vale per tutte le piattaforme – ti ritrovi la mamma a mettere like a uno sfogo tenebroso con cui cerchi di costruire la tua identità mediale ed è come quando gli adolescenti della generazione dei boomer la mamma andava a chiamarli al muretto. Che imbarazzo…
Ma al diavolo il muretto: quanto cringe in questa immagine! Scusate, sto ricevendo interferenze sul linguaggio. “Cringe” significa più o meno “imbarazzante” (ce lo spiega l’Accademia della Crusca, l’A-c-c-a-d-e-m-i-a della C-r-u-s-c-a… ma quanto sarà cringe?!). Ma può aiutarci a rendere l’idea di cosa sono le piattaforme intese come ambienti dove ci trovi anche la prof. di latino con le sue ricette, quella di italiano con le sue campagne di sensibilizzazione ambientale e il prof. di fisica con il suo podcast. E allora se sei un adolescente è davvero difficile. E che fai? Ti sposti. Sul muretto più lontano. Sul muretto di Instagram, di Snapchat, di TikTok, di quel nuovo ambiente che noi conosceremo solo quando ne avranno parlato i media mainstream, ovvero quando i ragazzi lo avranno già lasciato per quello successivo (dove però non mancano mai gli influencer della pubblicità né le bestie della politica: cringe entrambe le categorie, ma questo è un altro discorso e forse un giorno lo svilupperemo).
Ma basta chiacchiere. La cornice è sufficientemente delineata. Passiamo al quadro.
Paesaggio con ragazzi e ragazze
Esatto, paesaggio con ragazzi e ragazze, e non riesco a pensare che a questa scena di Kasaba, diretto dal turco Nuri Bilge Ceylan nel 1997.


- I protagonisti sono gli studenti e le studentesse della scuola secondaria di secondo grado.
- Il contesto è quello del progetto RApP.
- L’occasione è stata propiziata da SECOP edizioni che ha organizzato un concorso letterario per studenti e studentesse sui temi dell’Agenda 2030.
Due parole su RApP, che sta per Ragazzi e Ragazze Apprendono tra Pari (in questa sede sarebbe troppo lungo descriverlo nel merito, per cui vi rimando al sito web informativo) e che prevede, in estrema sintesi, l’invito “Fai sentire la tua voce”, come recita il titolo di una canzone scritta, musicata e cantata dai ragazzi RApP della prima sperimentazione del 2019.
Da allora sono state tante le iniziative che hanno dato la parola ai ragazzi e alle ragazze RApP: un PON sullo Storytelling, un dibattito tra pari nel Salone dei Cinquecento di Palazzo Vecchio a Firenze, un Convegno Internazionale con l’Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale, il primo posto al bando MIUR sulle Competenze Digitali e di Cittadinanza, con una rete di 7 scuole su tutto il territorio nazionale.
Il concorso letterario di cui stiamo parlando è l’ultima iniziativa RApP in ordine di tempo: è stato pensato da SECOP edizioni e gestito dal gruppo di progetto RApP con il supporto di SecopLab, con la supervisione della prof.ssa Lorella Rotondi e con la partecipazione degli studenti e delle studentesse dell’ISIS Gobetti-Volta di Bagno a Ripoli (Firenze).
Nella sua prima edizione è stato dedicato alla memoria di Aaron Swartz e ha permesso di selezionare 15 racconti che sono andati a confluire nel volume che li raccoglie, La tela digitale, 162 pagine che vedono autori 42 studenti e studentesse.
Questi che seguono sono i nomi, che doverosamente e felicemente elenco (in ordine alfabetico):
Alessandro Pacini, Andrea Bochicchio, Aurora Bettini, Ayoub Sarrar, Cosimo Paoli, Davide Pietrini, Diego Cattedra, Duccio Latini, Duccio Seri, Emiliano Biondi, Enriko Zdrava, Filippo Bonciani, Filippo Bronzi, Filippo Santoro, Francesco Buti, Francesco Severi, Gabriele Messina, Giulia Ugolini, Giulio Conciarelli, Harold Rosales, Julio Villanueva, Leonardo Celenza Carone, Letizia Ariano, Lorenzo Berlincioni, Lorenzo Clemente, Lucas Melo Alves, Maria Giulia Ciobotaru, Martina Secori, Matteo Bernini, Matteo Falleri, Mattia Antongiovanni, Mihaela Spirache, Mirko Tacconi, Neri Ducci, Niccolò Bragetta, Niccolò Maurri, Niccolò Oldoli, Niccolò Parmigiani, Pietro Rovai, Riccardo Lumare, Tommaso Pietrantoni, Viola Pelli.
Hanno scritto, singolarmente e in gruppi, i 15 racconti che danno corpo a La tela digitale. Se siete curiosi date un’occhiata all’indice e scaricate la prefazione di Peppino Piacente, se siete amanti della lettura prenotate una copia del libro. Se invece siete come noi e volete assumervi il dovere di ascolto nei confronti di questi ragazzi e queste ragazze a cui è stata data la parola, questi che seguono sono i primi due racconti che abbiamo sviluppato in forma di audionarrazione (si raggiungono da un QRcode stampato in apertura del libro, ma ci fa piacere condividerli anche qui):
L’antologia La tela digitale presentata al Salone del libro di Torino
Il 15 ottobre 2021 al Salone del libro di Torino è stata presentata l’antologia di racconti La tela digitale. A cura di SECOP edizioni, presso lo stand della Regione Puglia, con un intervento del prof. Gianluca Simonetta e della prof.ssa Lorella Rotondi. Ma soprattutto con un inedito racconto a cura dei ragazzi e delle ragazze del progetto RApP che hanno scritto i racconti, e che ancora una volta hanno fatto sentire la loro voce dimostrando la loro autorialità.




42 giovani autori, per usare il lessico di un editore da carta stampata. Ma anche 42 giovani creators, per usare il lessico che l’editore da carta stampata ha cominciato a frequentare da quando ha avviato l’iniziativa Secop Lab, ovvero un laboratorio creativo che dà spazio a giovani studiosi di comunicazione digitale.
Cosa significa creators lo sappiamo tutti. Sono i ragazzi e le ragazze che creano i video su YouTube, le storie su Instagram e tutto ciò che compare online nelle varie piattaforme. Ebbene, il libro di SECOP edizioni che raccoglie i 15 racconti scritti dai ragazzi e dalle ragazze delle scuola secondaria di secondo grado è stato concepito (anche) come una sorta di piattaforma-di-content-creation-a-stampa.
Per postare non si clicca un bottone come sulle piattaforme di social media, ma si riempie comunque un’area di testo: quella del documento su cui hanno scritto i partecipanti al concorso.
È successo poi che altri ragazzi hanno avviato l’iniziativa di svilupparli in forma di audioracconti e allora la piattaforma-di-content-creation-a-stampa è diventata anche una piattaforma-di-conversazione-creativa, aperta al remix e al resto delle operazioni tipiche delle “culture partecipative” di cui parlava Jenkins in uno dei più bei libri di comunicazione degli ultimi anni: Culture partecipative e competenze digitali. Media education per il XXI secolo.
Se siete arrivati fino a qui siete dei lettori coraggiosi.
Se poi siete studenti/esse o insegnanti e vi è venuta voglia di partecipare, visitate la pagina di presentazione della seconda edizione del concorso e iscrivetevi con la vostra classe.
Vi aspettiamo!
Sei un insegnante?
Vuoi partecipare con la tua classe alla prossima edizione del concorso letterario DIGITale?
Info più dettagliate? Eccole qua!
I riferimenti completi alla raccolta di racconti La tela digitale:
- La tela digitale. I racconti del Concorso DigiTale, SECOP edizioni 2021
Pagina dedicata sul sito dell’editore
Il sito informativo del progetto RApP:
Il volumetto che racconta alcune delle esperienze RApP:
- Rotondi L. (a cura di) (2020). Progettare con i Ragazzi un Nuovo DIGITALE UMANO
[pagina dedicata sul sito della casa editrice]
I due libri a cui si fa riferimento nell’articolo (due dei più bei libri di comunicazione in circolazione):
- Jenkins H., Purushotma R., Weigel M., Clinton K., Robison A. J. (2010). Culture partecipative e competenze digitali. Media education per il XXI secolo
[preview online]
- danah boyd (2014). It’s complicated. La vita sociale degli adolescenti sul web
[prevbiew online] [free download sul sito dell’autrice – in inglese]